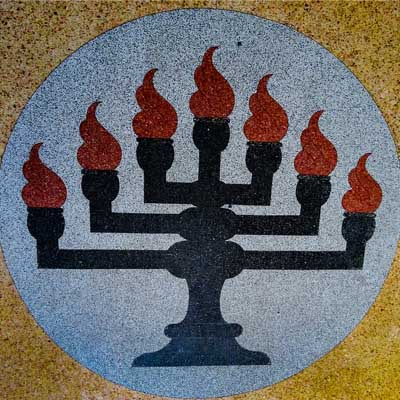Eresie, rivoluzioni interiori. Nascondono malcontento verso le istituzioni. Stigmatizzano lo scollamento tra i privilegiati al governo ed il popolo ignorato.
In effetti, laddove esista abbandono è più facile trovare un’istituzione sostitutiva; più efficace, presente e vicina. Disposta ad ascoltare i problemi di pochi.
E se incaselliamo questo discorso nell’Italia della seconda metà del 1800, possiamo capire certe complesse dinamiche di un microcosmo che ignorava completamente lo scenario politico e sociale della nostra penisola.
Tra la Maremma ed i monti più interni sui quali svetta l’Amiata, i confini nazionali erano quelli del campo dove si lavorava duramente, del paese dove si abitava, dei pascoli del bestiame. Il mezzo d’informazione era il “sentito dire” e c’erano grosse sacche di ignoranza ed analfabetismo.
Questo portava ovviamente ad un’esistenza più intimista. Eventuali sensibilità presenti in determinati individui “dotati” erano sicuramente amplificate. E così fu per il quattordicenne David Lazzaretti che, nel 1848, caricando da solo della legna in una macchia isolata, ebbe il suo primo contatto metafisico.
Vide uscire dalla boscaglia un frate che gli parlò, per poi sparire nuovamente dalla sua vista. Nulla di strano se quello stesso frate non gli si fosse ripresentato più volte nel corso degli anni finché, a detta di David, si rivelò come San Pietro.
Su queste basi, David elaborò la costruzione della sua missione, impostando su questa tutta la sua vita grazie anche al continuo apporto di esperienze che lui chiamava Sogni e Visioni dando anche questo titolo ad una sua prima pubblicazione nel 1871. Psicologicamente il suo comportamento è stato attribuito semplicemente ad una reazione verso il clima religioso e sociale dell’epoca, ma in realtà il suo fu un vero e proprio progetto sociale calato in quella realtà dove viveva.
Ed ogni progetto sociale non è individualista, ma riguarda una comunità. Il suo era improntato a fini umanitari e sociali. Lo costituì nel 1870 e, pur somigliando ad una società di mutuo soccorso, aveva tutte le caratteristiche di una struttura socialista; infatti il lavoro era organizzato socialmente e tutti i beni erano messi in comune. La sostanziale differenza di questa struttura stava nel fatto che non era politica, ma religiosa. Si trattava di una nuova religione che si rifaceva ad un’idea di Chiesa istintiva e popolare. David Lazzaretti stabilì e ne stampò finanche le regole, ma non ebbe mai l’avallo della Chiesa che non volle vedere in quella struttura un nuovo ordine monastico.
Alle sue insistenze, fu convocato al Vaticano nel 1878 per essere bollato come eretico. Prendendo la cosa come un affronto alla sua missione, rivelatagli dallo stesso San Pietro, da parte di una Chiesa che oramai non aveva più un senso, obsoleta e non più testimone di una missione affidatale, si autoproclamò “Nuovo Cristo”, Giudice e Guida per le genti adottando il simbolo dello Spirito Santo.

Questa proclamazione solenne e portatrice di una nuova era sarebbe stata sancita da una grande processione con la discesa di David, il “Messia dell’Amiata”, dal Monte Labbro.
Era il 1878. A valle, la polizia appoggiata da alcune truppe dell’esercito era in attesa. La vita di David Lazzaretti finì con una palla di fucile in fronte. Altri tre morti, molti feriti e gli storici tutti concordi sull’inutilità di questo spargimento di sangue.
David Lazzaretti oggi
A Monte Labbro, sul versante sud-occidentale del Monte Amiata, tra il Lago di Bolsena e Siena, oggi è ancora attiva la sua Comunità Giurisdavidica dove si trova l’eremo di David, la torre e la cappella.
Per chi intenda approfondire l’argomento c’è il Centro Studi David Lazzaretti ad Arcidosso.
A Roma, fino al 21 maggio, presso il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari è presente la mostra a lui dedicata a cura dello storico dell’arte Leandro Ventura.
Il 20 maggio, nel Salone d’Onore del museo, ci sarà il concerto spettacolo di Simone Cristicchi “Il secondo figlio di Dio”. Cristicchi, che si autodefinisce un “antiquario della memoria”, si è imbattuto in Lazzaretti per la prima volta proprio sulle pendici del Monte Amiata nel 2008 e ne è rimasto colpito sia per il culto popolare, sia per l’interesse di storici e letterati (Maupassant, Croce, Pascoli, lo stesso Antonio Gramsci ed un Cesare Lombroso intento a studiarne il cranio per dimostrare la sua follia).
Lazzaretti è uno dei tanti
Ma si poteva definirlo folle? Non più delle pastorelle di Fatima, della Bernadette di Lourdes, dell’indio sconosciuto che vede rivelarglisi il suo Dio… Uno dei temi principali del mio libro Nodus Concursionis Temporis è proprio la manifestazione di un’energia primordiale all’essere umano. Ho fatto diverse ricerche sulle cosiddette Apparizioni Mariane: sono legate a luoghi particolari, luoghi che concentrano questa energia (veri e propri Nodi) e materializzano qualcosa in base alla coscienza, al credo, ai più forti sentimenti latenti di chi vi si trova. L’apparizione più frequente è una donna: figura rassicurante, non ostile, materna che per il mondo Cristiano è subito identificata con la Madonna. Lazzaretti ebbe questa materializzazione (e le seguenti) in forma maschile; la identificò con San Pietro, probabilmente perché figura paterna ed autorevole, più vicina al suo modo d’essere.
Non credo assolutamente che fosse folle. Credo solo che la Società Umana, in ogni epoca, ad ogni latitudine ha il terribile difetto di voler omologare qualunque cosa.
E questa è negazione di libertà e crescita.